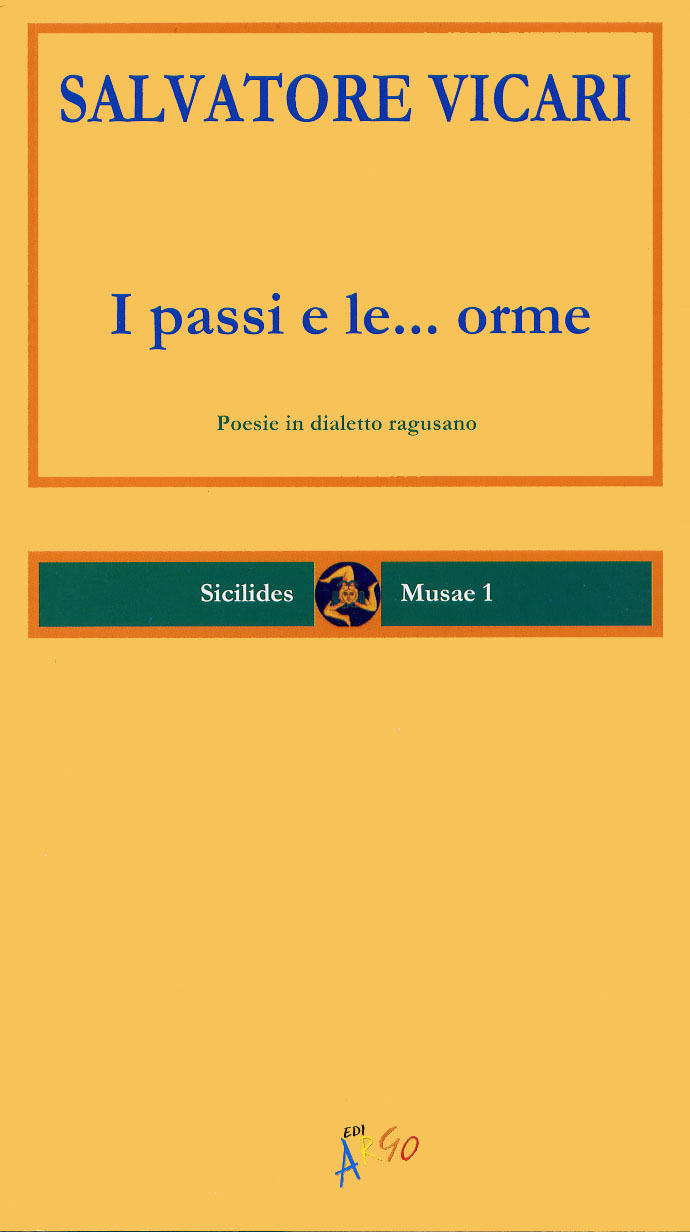
PREFAZIONE
Le descrizioni del paesaggio rurale e gli usi e i costumi che appartengono
a un passato quasi remoto, trascendono la realtà immanente e trasportano
autore e lettori verso qualcos’altro. In realtà la campagna
ragusana è quella che il poeta collega alla propria infanzia
Poesia della memoria, quindi, quella di Salvatore Vicari, una memoria
tutta particolare e circoscritta alla ruralità. Ma quel mondo contadino
d’altri tempi, strettamente collegato a un passato storico, oggi
non è più identificabile, anche se, per l’autore,
è assolutamente attuale. Si tratta di un mondo direttamente collegato
ad una struttura familiare, costituito da tre principali entità:
il padre (che è anche il maestro, l’educatore, l’esempio),
la madre (che è amore, compagnia e solidarietà) e la divinità
(Cristo, la Madonna, lo Spirito Santo). E’ un mondo poetico, estremamente
circoscritto e lineare, dove la famiglia viene inserita in un società
primitiva e contadina.
Questa è la tematica costante di tutto il libro, dove non si va
al di là del soggettivo, anche se non mancano osservazioni e metafore.
La semplicità di itinerario poetico ricama una storia fatta di
antiche quotidianità e di ordinarietà, a riprova dell’animo
sensibile del poeta.
Si tratta di una poesia affabulante, capace di mutare in arcano, a volte,
anche il gioco di un mondo arcaico e di estrema semplicità, che
rappresenta il segno di una memoria prolungata. La nostalgia è
implicita in quanto Vicari, che probabilmente prova ad avere rapporti
con il lirismo e un certo tipo di musicalità, si limita a una descrizione,
a volte elencativa, da cui si deduce la necessità di un ritorno,
anche se solo col ricordo, ad un mondo elementare, in contrasto col mondo
contemporaneo, non solamente elettronico, ma anche sostanzialmente alienante.
Vicari
offre al lettore un linguaggio semplice, ma curato e intenso, in uno stile
ispirato a una sostanziale semplicità espressiva. Poesia ricca
di candore, in diretta dipendenza dalle radici, sia linguistiche che psicologiche,
e che trasporta il lettore lungo un percorso ricco di autenticità.
Questa raccolta di versi può essere considerata un recupero del
tempo perduto, col preciso obiettivo di poter focalizzare un passato ben
determinato e ben datato: quello dell’infanzia dell’autore
e dei suoi genitori, come erano, quando lui era adolescente. E la campagna,
con il suo mondo e i suoi costumi dell’epoca, è il palcoscenico
dove è stata recitata la commedia dell’infanzia. La natura
descritta è la precisa proiezione di un bisogno e di un ricordo.
Il seminatore, i mietitori e i pastori non esistono più, così
come sono descritti nelle poesie, come non esiste quel mondo rurale, ma
tutto diventa parte del ricordo e metafora della vita.
E’ chiaro che l’autore considera se stesso, di volta in volta,
seminatore, mietitore e pastore e, così, tutto riacquista un senso.
La tematica del libro si trova nei primi versi della poesia “Muddhichedhi
r’amuri”: “Mathri, ca u piettu o natali mi rasti...
e a cammisedha… / e-ttu, pathri, u sapuri rô sali e i scarpi...
e u timuri… Ratimi… a-mmia siminaturi / semenza”.
E si fa esplicita la religiosità (anche questa, in fondo, di tipo
rurale) nella lirica ”Ssi jòrna”: “Io, a Ttia
nunn’è o-spissu ca Ti ciercu e... mi ni lori / ma u stissu
/ se-Tti viru Ti canùsciu / unu... umanu ri vicinu /... e-ttrinu
/ criru... ddhivinu ri luntanu, siminatùri ri spranzi“.
Conclude con l’elogio della terra di Sicilia…”rrustica
rrera ri uommini …ri fìmmini bbedhi… ardhienti ri cori…
gghiènti nusthrana… canta …pp’allicrizza o ppi
rragghia / ’n coru ê so figghi e i niputi… stizzi ri
sangu… ri chista terra… nosthra Sicilia r’amuri”.
Non mancano soluzioni tecniche felici e versi di una certa suggestività.
Ma è il tono commosso e partecipativo il maggior pregio del libro,
a dimostrazione di come questo mondo, che potrebbe apparire arcaico e
superato a chi non lo ha vissuto, sia parte integrante dell’autore,
che lo vive in assoluta simbiosi.
Emanuele Schembari
PRESENTAZIONE dell'autore.
L’uomo è incline
a riesumare il proprio passato, gli anni giovanili, frugare nella memoria,
rivivere episodi particolari. E a raccontarsi e a raccontare, ai figli,
ai nipoti, agli amici: ”la guerra… l’America…
quando io ero ragazzo…”, ancor di più da anziano, cresce
il bisogno di trasmettere la propria esperienza…” stai attento…
ai miei tempi…”
Meno memoria resta della prima fanciullezza, che, invero, è vissuta
in parte in modo inconscio, spesso con il fastidio legato all’ansia
di crescere, di indossare i pantaloni lunghi come i grandi. Ed in modo
inconsapevole si registrano le sensazioni, i percorsi, le parole…
Poi, da “grandi“, quando l’anzianità sbocca nella
vecchiaia, è proprio vero che si ritorna fanciulli, e si ha bisogno
di protezione e comprensione. Ed è allora che riemergono i ricordi,
piuttosto larvati, magari deformati; immagini, flash istantanei, pensieri,
parole da tempo dimenticate. Sono le monadi di Leibniz? il cogito di Cartesio?
le idee dell’iperuranio di Platone? Forse un po’ di tutto:
mistero e meraviglia della mente umana.
Nella stagione della maturità, sul “viale del tramonto”,
la memoria è lo specchio sul quale si cerca l’immagine del
fanciullo, come sul fondo di un pozzo, prima che il sasso caduto la cancelli,
riportando alla realtà. E allora i passi sono più lenti
e le orme più profonde, per il peso del corpo e degli anni. Il
passato diventa attuale e il futuro si impone come proiezione dell’esperienza
trascorsa. Le orme in ogni istante coincidono con i passi, sono congruenti
alle precedenti e lo saranno con le successive.
Quando ci si accinge a scrivere, si cercano nella memoria le immagini
e le parole. Ancor di più se alita l’ispirazione della poesia.
Sono le assonanze, la ricerca della rima, della metafora, degli accostamenti
alla realtà, di dire senza dire, per lasciare intendere a chi vorrà
ascoltare, e inventare un messaggio. Allora la poesia vince la noia, la
solitudine, allunga la vita.
La mia fanciullezza ha avuto un primordio agreste e affonda le radici
nella “mia” terra, la generosa pianura del ragusano. Ora,
con i ricordi, emergono gli odori, i sapori, i rumori della pioggia e
del vento, quasi il fruscìo delle erbe che crescono… Ed è
prepotente il bisogno di… dipingerli con i versi, con quelle parole
dialettali infisse come chiodi nella mente. Ma la memoria è tuttavia
filtrata, per formazione (o deformazione?) dalla lunga esperienza professionale,
per cui tende ad avere un taglio scientifico razionale come si nota in
buona parte da quel che dico e scrivo.
Da pensionato, dopo aver speso il mio tempo e le migliori energie prevalentemente
nell’insegnamento, ho scoperto questo meraviglioso filone della
poesia dialettale, con la quale mi diletto a rivisitare le nozioni apprese
dagli studi liceali e universitari. Così ho pubblicato due libri.
Con il primo, “ U LUOCU, U TIEMPU “ (ed. LibroItaliano 1998)
mi soffermo sulle due grandezze fondamentali Spazio e Tempo, assolute
per Newton, relativistiche per Einstein, e, nella mia metafora poetica,
lo Spazio diventa l’estensione piana della palma della mano divina
e il Tempo l’estensione lineare del suo palmo, dal pollice, che
spinge il sole, fino all’indice, che ne indica l’andamento
uni-verso.
Con il secondo, “U SULI QUATHRATU” (Libreria Paolino editrice
2002) ho rivisitato uno dei problemi più affascinanti della matematica:
la quadratura del cerchio, cioè la costruzione geometrica di un
quadrato equivalente ad un cerchio. Il grande Archimede ha trovato il
rapporto tra la circonferenza e il suo diametro, il famoso p, che però
è un numero trascendente e non è quindi costruibile un segmento
che abbia tale misura con strumenti meccanici, quali riga e compasso.
Pertanto il problema è rimasto irrisolto nei secoli. Nella mia
metafora l’ho risolto poeticamente immaginando che un aquilone,
sfuggito dalla mano di un ragazzo, spinto dal vento, vada ad incollarsi
sul sole rendendolo quadrato.
Ora con il terzo, “I PASSI e LE ORME“ mi piace interpretare
l’idea del “tutto scorre” (i passi) secondo il divenire
di Eraclito, e del “tutto è” (le orme) quel che resta
fermo, secondo Parmenide.
Potrebbero sembrare argomentazioni troppo pretenziose per un libro di
poesia dialettale, ma sono concetti talmente radicati in me, che ora affiorano
prepotentemente nella mente.
Memoria quindi, senza essere nostalgia, di quella stagione della vita
in parte vissuta in tempo di guerra. Un fiume vorticoso di ricordi che
vedo scorrere sotto gli occhi della fantasia, come spettatore curioso
e affascinato.
I passi, il moto, l’avanzamento, sono il presente che si proietta
verso il futuro. Le orme quello che resta, la traccia, il passato.
Il padre-guida e il figlio-discente, la mano e la manina, in cammino,
insieme per un lungo tratto, in una sorta di simbiosi, intrecciano i loro
passi.
Sul far della sera, su quella strada, un’ombra è più
lunga, mentre la più corta rimane coperta. Le orme, le grandi e
le piccole, sono parallele, pur convergenti, per quella reciproca interazione
magnetica affettiva che è il “legame del sangue”. Ancor
di più se la manina è quella del nipote, il figlio del figlio.
Le orme saranno il preludio di nuovi passi verso l’eternazione della
stirpe. Le foglie morte cadute e la polvere, le copriranno. Con il nuovo
giorno solo un’ombra si staglierà sulla strada: senza il
confronto, sembrerà grande, quella di un uomo maturo. La separazione
è stata inevitabile: è legge di natura: c’è
chi si ferma e chi continua l’opera, verso una nuova meta.
Il progresso, l’invenzione, la scoperta, anche la guerra e la rivoluzione,
cambiano il mondo. Sarà la storia a raccontare le conseguenze alle
generazioni future: “Ai posteri l’ardua sentenza“.
La lezione del padre maestro e del figlio alunno, nel giuoco infantile
dei passi e delle orme, è la metafora dell’umanità,
dello stesso progresso scientifico e culturale. Tutto viene da un passo,
una leva, una ruota, da un cammino che procede e tutto avrà un
seguito in un altro passo, un altro cammino.
L’universo, generato in un’esplosione cosmica, il big bang,
è in espansione e, anche se impercettibilmente ai nostri sensi,
fatalmente si avvia verso l’implosione. Forse per riprendere una
nuova esplosione, un nuovo big bang. Una sorta di albe e tramonti cosmici.
Un qualunque meccanismo, in ogni azione, sviluppa calore. In opportune
condizioni il calore può rigenerare movimento, cioè una
forza lavorativa, per mezzo di una macchina: per esempio la locomotiva
a vapore o più semplicemente il coperchio che si solleva sulla
pentola quando l’acqua bolle. Per non dire delle centrali atomiche.
Un succedersi ciclico di trasformazioni termodinamiche: ma per il principio
dell’Entropia l’energia meccanica tende ad evolvere in una
massa di calore isotermico, non più trasformabile in energia meccanica,
cioè in lavoro. Sarà la paralisi dell’universo, la
sua morte cosmica.
La Scienza tende a scoprire i percorsi della natura, nei suoi grandi passi,
ne enuncia le leggi con linguaggio matematico, quali la gravitazione universale,
la struttura atomica, le onde elettromagnetiche, ecc. individuando un
comportamento sorprendentemente razionale, pur trattandosi di materia
inerte. Si ha la consapevolezza di sentire la immanenza di quella Mano
che ha programmato e ordinato l’Universo.
Puitáta
Pethri…
Poiesi
Pietre
Scarpi ruossi
Unni vai, puisia
Bburrasca
Mirenna
Palumma
A sira ciovi
Scarpe grosse
Dove vai, poesia
Burrasca
Merenda
Colomba
La sera piove
Ciamànniti, mathri
Chiamandoti, madre
Mura a-ssiccu…
U muragghiu
Muri a secco
Il muraglione
U sirìlli ri petrha
U vignànu
A máccia ri nuci
Pathri
Manu
Il sedile di pietra
Il terrazzino
L’ albero di noce
Padre
Mani
Pàmmini
A cianciana
Ssa porta
Tu, luci…
I jòrna
Armenu na vota
Muddhichedhi r'amuri
Foglie
Il sonaglio
Quella porta
Tu, luce…
I giorni
Almeno una volta
Briciole d'amore
Gocce di eterno
Sicilia d'amore
POSTFAZIONE di Andrea Guastella
LA NATURALEZZA DELLA POESIA
“Arma mia – ràpimi
– e ddhimmillu… comu si fa a nun gn’ èssiri pueta?”
Come si fa a non essere poeta? Per l’anima bambina che si guarda
intorno, fiuta l’orientamento, scruta, tutto è nuovo, tutto
è occasione di meraviglia e pretesto per il canto. Da tale apertura
di puro stupore scaturisce una lirica che imbocca senza esitazione e,
apparentemente, senza sforzo i cammini della memoria. Non della solita
memoria oleografica a cui ci ha assuefatto tanta poesia in dialetto. La
memoria dell’ultimo libro di Salvatore Vicari è piuttosto
una memoria nativa, scevra di sedimenti e di incrostazioni culturali.
È la tradizione di cui parlava Eliot , in cui si innesta in modo
autonomo la visione del mondo dell’autore. E se, forse, il repertorio
di pastori e muri a secco cui attinge può apparire attempato, non
lo è certo lo spirito inquieto e interrogante che la informa, sicché
essa invecchia come il vino buono, o come pitture che mai ci sogneremmo
di chiamare vecchie, semmai antiche, perché continuano, nonostante
gli anni, a testimoniare il loro splendore con l’evidenza della
ragione e la forza di una passione che trabocca.
Sfilano così, sul palcoscenico noto della campagna siciliana, oggetti
che nessuno, al di là del poeta, sa vedere – “ vavaluci
/ â-ggniddhuzzi ciunchi ca ciàmunu i so mathri “ –
e che, una volta abbracciati e conosciuti nella comune essenza creaturale,
ci fanno consapevoli dell’universale fragilità: “ Ma
cci tuornu – ddhuocu - quann’è ll’ura / barbàniu
anzièmi ê vavaluci / spièrsu ammienzu ê spini
/ […] / menthri a sira cala / e cciovi – làcrimi ri
nùvuli – ciùsi ciùsi ( Pethri ).
Ora, è appunto col restituire l’uomo allo stato di natura
che la poesia di Vicari esercita il sommo grado la sua funzione morale,
che non è tanto quella di rispondere agli innumerevoli “perché“
suscitati dal reale, quanto quella di indicarci il nostro limite, affinché
impariamo a trascenderlo o, almeno, ad accettarlo.
Questo l’insegnamento del padre del poeta, vero nume tutelare, cui
sono dedicate pagine tra le più toccanti de “I PASSI e LE
ORME”: la lirica Pathri, già apparsa ne “U SULI QUATHRATU”
e ne “U LUOCU, U TIEMPU”, dove il figlio si ritrova ombra
nella luce paterna, nonché il testo che dà nome alla raccolta.
Qui il ritmo franto e alternato, come un flusso di coscienza, da continue
pause e sospensioni, regala momenti di contemplazione assoluta, con la
mente che pare distaccarsi dal corpo e
vivere eventi di altri tempi in altri luoghi: “ Si rici: fuorsi
‘n-numani si torna / àuthri terri? àuthri gghiènti?
/ i culura armenu putissi…stissa ùmm’ra e ll’arma
/ e a mamoria / ar’aspittari / tacita ‘ntisa – rrincunthràriti
- pinziriùsu – ddhu filidhu ri fumu / ‘mmuzzicuni ri
sìcaru ntô labbru / ùnicu sfizziu / e-ll’uocci,
pathri, e i to manu ràpiri / ancora ppi n’ura simenza –
nthra i jta luonchi - ruppa - rani ri rrusàriu “
Versi del genere, spontanei come per il contadino seminare, o per il venditore
ambulante bandire ai quattro venti la sua merce, ma al tempo stesso calibratissimi,
studiati alla scuola della grande letteratura novecentesca, sono quanto
di meglio il dialetto abbia oggi da offrire e garantiscono a Vicari un
posto di rilievo nella nostra poesia vernacolare.
Andrea Guastella
LA RECENSIONE DI LINA RICCOBENE
I "PASSI E LE ... ORME" di Salvatore Vicari hanno lasciato sempre segni indelebili sulle pagine bianche da riempire di versi e di autentica poesia in lingua siciliana ......
La presentazione del libro al Liceo Classico Umberto I
Le
foto della presentazione del libro al Liceo Classico Umberto I