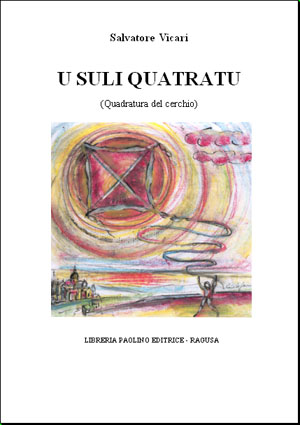
PRESENTAZIONE
Dopo " U LUOCU, U TIEMPU " ( ed.1998 )
Salvatore Vicari ci propone
una seconda raccolta dei suoi versi forti ed efficaci sia sotto
l'aspetto tecnico che sotto quello del contenuto; ma con un'ulteriore
maturazione , come dimostrano alcune composizioni già pubblicate nel primo
libro e ora qui di nuovo presenti, in qualche modo rivisitate. E questo
è il segno inconfondibile del rigore matematico e scientifico, dell'uomo
che è il nostro poeta, istintivamente e professionalmente portato a provare,
riprovare, a rifare i conti, a rimettere ordine, a far passare la materia
trattata sotto il vaglio della logica e della ragione. Il che potrebbe
sembrare la negazione della poesia. Ma non è così. Perché, altrimenti,
dove starebbe il mistero e il fascino della poesia stessa?
Il Vicari
ci si presenta, dunque, fuori dagli schemi più consueti del settore letterario,
verso cui nella piena maturità intellettuale, e oltre, si è sentito attratto
prepotentemente. E lo fa con voce profonda, nello stesso tempo antica
e moderna; antica per il sentire epico dei valori umani intimi, familiari
e sociali, moderna per la dimensione libera dei versi, ubbidienti soltanto
ai ritmi interiori dell'anima e all'esigenza di pause ora brevi ora lunghe,
di frasi ora di ampia movenza ora di taglio incisivo, di immagini ora
realisticamente descrittive ora lievemente sfumate, poeticamente allusive
e ricche di metafore.
La raccolta, sviluppata in tre sezioni, non offre un
tessuto contenutistico uniforme, ma sapientemente graduato attraverso
distinti stadi, cui comunque è sempre presente il gioco del sentimento,
della riflessione, della memoria, della speranza, in un tragitto in cui
il presente è soltanto una pausa in confronto agli ampi orizzonti del
passato e del futuro. Può renderne conto una breve analisi particolareggiata.
Nella
prima sezione ( U suli quatratu
) ricorrono soprattutto i temi del mistero cosmico, della natura, del
vivere sulla terra, con la presenza costante del sole come testimonianza
perenne di una forte ansia di illuminare ogni piega dell'esistenza e di
penetrarne il mistero.
Perciò
è ricorrente un certo realismo descrittivo unito al desiderio di esplorare
e di conoscere, ma non disgiunto da fugaci sentori di nostalgia e di improvvise
proiezioni verso il futuro in un mescolarsi di motivi quali la giovinezza,
la vecchiaia, la morte, armonizzati dal denominatore comune di una profonda
religiosità che si avvolge nel mistero. Tutto questo ci annuncia la lirica
di apertura, che non a caso dà il titolo al volume, dove la fantasia crea una situazione surreale con efficaci effetti
simbolici: le più grandi scoperte e i risultati più esaltanti sono dovuti
spesso al verificarsi di situazioni imprevedibili, quasi attraverso un
gioco strabiliante che evidenzia una realtà stupefacente. I versi rivelano
subito un animo fanciullo e insieme rigorosamente riflessivo proteso verso
la ricerca e la speranza di approdare a quanto di più sconvolgente è contenuto
nella vita universale. Il libro si apre, dunque, con un autoritratto spirituale,
che si sintetizza nel titolo, proiettato poi sull'intera raccolta, dove
continuamente si percorrono itinerari segnati da punti di sosta variamente
tesi a cogliere momenti di vita che via via, partendo dalla fanciullezza,
focalizzano la giovinezza, l'età matura, gli anni estremi, sempre protesi
attivamente verso un futuro che non avrà mai fine. E questa determinazione
dell'uomo-Vicari a penetrare nelle leggi della natura, addirittura dell'universo,
a valicare i limiti entro i quali egli si sente chiuso, giganteggia nella
seconda composizione ( 'M puntu
r'appuòiu ): Ahi putissi …truvari putissi n appuojiu / unni ciantàricci i pièri / e
cchê manu u munnu ammuttari , dove
non mancano, tuttavia, elementi di contemplativo
abbandono lirico : E a sira, se
a luna ti spogghia e ti curca, / nun vali se 'rrestunu i stidhi, tanti,
ma fridhi e 'mmiriusi Così pure in
Armenu na vota salta
in primo piano il ricercatore ( e
vìrriri u munnu, siènnu ch'è ttùnnu, / cu è ca i fila cci tira / e ccomu
gghira ) animato dal desiderio di evadere dal peso della realtà comune per capire il
funzionamento dei meccanismi planetari, per poi, acquietato, raccogliersi
serenamente in solitudine nella propria casa e vivere la vita, come viene,
in attesa della fine: Ma â sira,
/ prima ca scura, / vuògghiu turnari â casa / e stari sulìdhu, 'rricugghiùtu
/ ar'aspittari / macari mutu, / rô rriestu râ vita / ca scùrrunu i peni comu veni .E mentre si proietta verso il
futuro, nella speranza e nell'attesa
( Canzuna ), il poeta rievoca la giovinezza
con un pizzico, si, di malinconia, ma soprattutto come motore di un'esistenza
che non rinuncia mai a desiderare ciò che è naturalmente bello , riposante,
piacevole (…rusidhi ri maju, …cantari
cuntentu,..mùrmuru r'unna).Successivamente ( Cumedia rusticana ) possiamo ancora notare
una distaccata considerazione del trascorrere della vita verso la fine
del suo percorso, ma con dentro l'ansia di conoscere al meglio possibile
la vita stessa, la realtà, le leggi dell'universo e, soprattutto, di squarciare
il mistero dell'eternità. Cosa che, comunque, non implica una rinunzia
alla vita, perché, soddisfatta la conoscenza dell'oltretomba, il poeta
vorrebbe potere avere macari u bbiglièttu ri rituornu.
Nella
seconda sezione ( U sirilli ri
petra ), pur permanendo la costante della descrizione realistica e
delle figurazioni allusive , sempre nell'uso di un linguaggio concreto,
senza orpelli letterali o accademici, i contenuti risultano più intimi,
la curiosità scientifica e naturalistica cede il posto a riferimenti più
umani, a richiami più affettivi, a rievocazioni di tipo sentimentale riguardanti
la giovinezza del poeta, le sue origini, le figure familiari della madre
e soprattutto del padre perduto, con l'espressione dell'anelito
religioso al ricongiungimento ( A
tia patri ) o del richiamo dei tempi lontani anche attraverso il ricordo
di piccole cose o di situazioni solo apparentemente insignificanti (Ntô scurari, ciovi ) oppure dell'orgoglio di appartenere al mondo
spirituale e culturale dove a scarpi
ruossi corrisponde u cirviedhu cciù finu ( Scarpi ruossi ). Così, filtrati attraverso
le suggestioni della memoria, emergono i gesti del seminatore ( Siminaturi ) avvolti in un'atmosfera solenne
e religiosa (e a ogni ppasso, rapiènnu la manu , / a terra
'bbinirìci senza stola ), mentre il tema della morte si risolve come
principio di vita e come legge di natura al di là di ogni riferimento
ai valori della fede ( siennu a
morti simenza ri vita ).
La terza
sezione ( Matri terra ) continua sulla linea tematica della seconda, ma scandendo
in modo più specifico i contenuti e il senso delle tre tappe fondamentali
dell'esistenza : passato-presente-futuro. Si tratta, comunque, di dimensioni
di cui il poeta conserva sempre una lucida consapevolezza, senza sentimentalismi
scomposti, con l'equilibrio spirituale di chi sa bene che non ci si può
perdere o smarrire negli abbandoni nostalgici legati al passato, né nella
provvisorietà dei dolori o delle gioie del presente , né nell'incertezza
e nell'ansia che coinvolgono le proiezioni dell'anima verso il futuro,
persino verso quel futuro che si scioglie nell'infinito e nell'eterno,
dove i valori della fede religiosa, anche se non esasperati ed
enfatizzati, effondono vibrazioni
acquietanti. Così, nella lirica Matri
terra, al di là del classico
sentimento filiale e affettivo verso la terra natia e della fierezza dell'appartenenza
all'ambito della vita e della cultura contadine, troviamo la serena contemplazione
della morte come fatto naturale,
quasi gratificante : n annu si campa/
e 'ppuoi si mori /… / iu pïenzu e sïentu / quannu ri l'uomu / a stasciuni
rô tïempu veni ca si cïuri / ri l'aternu ca trasi / strittu ntê vrazza
tuoi, o terra ri spranza / gghià
si na gusta lu sapuri. E in Pammini
le immagini allegoriche e allusive della vita
che malinconicamente scivola verso il suo autunno si risolvono
nella speranza di una Luce, che è, sì, uno spiraglio vivo e fulgido, ma
mai tale da offuscare la dimensione del vivere terreno. Dove il presente,
con i suoi frastuoni e i suoi clamori stressanti, rievoca con nostalgia,
per contrasto, tenui rumori dei tempi andati ( Séntiri,
ri notti ) e, per associazione di idee, più composte abitudini familiari;
e c'è un voler fuggire dal presente ( luntanu
/ ntô scuru / mi fìngiu c'abbuolu ) magari non per recuperare un irreversibile
passato, ma per conseguire un futuro che meglio si armonizzi con quel
passato. Infine, esemplare, da questo punto di vista, la lirica che chiude
la raccolta (Ncutti rrica )
dove il poeta afferma che cerca di leggere nelle fitte righe della vita
per cogliere e capire le radici del passato, ma senza perdere di vista
il futuro, lasciando, tutto sommato, poco spazio al presente, che è un
groviglio in cui si incontrano e si scontrano i ricordi e le attese .
L'analisi
delle liriche qui non può essere che parziale; ma tanto penso possa bastare
per introdurre e invogliare il lettore
a gustare l'opera nella sua interezza. Mi preme, tuttavia, aggiungere
una considerazione conclusiva.
Ritengo
che vada segnalata, in questa seconda raccolta poetica del Vicari, un'evoluzione
e una crescita qualitativa di tipo contenutistico, con un ampliamento
dell'orizzonte che sembra veramente notevole. Infatti il nostro poeta
supera i limiti, direi canonici, della poesia dialettale, che generalmente
si tiene sulla curiosità popolare di costume, sullo scorcio realistico
di un paesaggio o di una situazione sociale, sul ritratto di persone o
cose, magari con piacevole tono oscillante tra il serio e il faceto. Invece qui troviamo la grande
tematica esistenziale, quella normalmente familiare ai poeti in lingua.
E il merito di Salvatore Vicari sta
nell'aver saputo adattare il dialetto a questa diversa
e non tradizionale situazione. Operazione non facile, ma qui perfettamente
riuscita, poiché il linguaggio è corposo, allusivo, ricco di metafore,
tipico del dialetto, riesce a proporsi
come veste ottimamente ritagliata su contenuti di dimensione universale,
che attengono non soltanto a un contesto paesano o regionale, bensì a
un problematica che appartiene
agli uomini in quanto tali, indipendentemente dal clima che li avvolge,
dal cielo che li sovrasta, dal sole che li illumina e li riscalda. Questo
senza trascurare l'impronta lirica e autobiografica, il marchio d'origine
di una terra e di un paesaggio inconfondibili, il colore e il calore presenti
nel sangue e nell'abito mentale, nella sicilianità dell'Autore.
U SULI QUATRATU
U
suli quatratu
'M
puntu r'appuòiu
Vuògghiu
abbulari
Palumma
Ô cielu r'aùstu
Armenu na vota
Canzuna
Cumedia rusticana
Ri juòrnu
e ntâ nuttàta
Frannùgghi

I FIUREDHI
U SIRILLI RI PETRA
Patri
Nto scurari,
ciovi
Scarpi ruossi
U sirilli ri petra
Siminaturi
Rumani è Natali
U signu râ cruci

U SIRILLI RI PETRA
MATRI TERRA
Matri
terra
Ô vientu ca sciùscia
Pàmmini
Ci tuorni
A sterna
Sèntiri
ri notti
U vignanu
Burrasca
Ncutti rrica

A STERNA